Cristologia: la sofferenza spirituale di Gesù Cristo
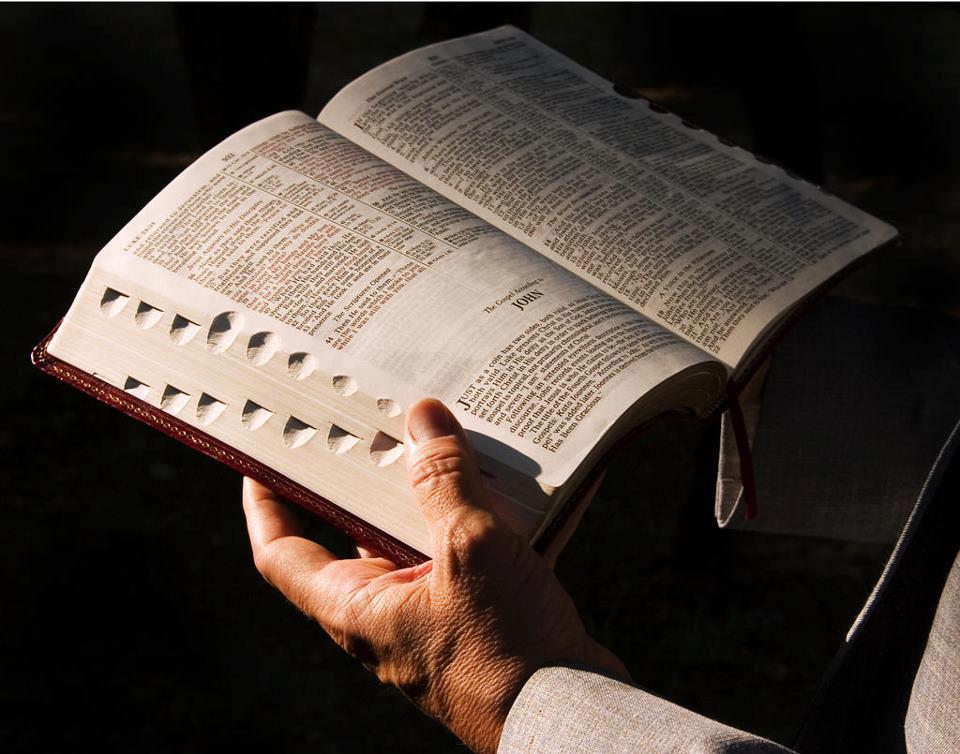
Cristologia: la sofferenza spirituale di Gesù Cristo
Anche trattando della sofferenza spirituale di Gesú, essenziale è non farsi idee proprie su di lui, Se no, è probabile che semplicemente si inventi, nell’idea: “Cosa avrei provato io in simili circostanze”. Tra i numerosi titoli cristologici, come Messia, Figlio di Dio, Salvatore… ce n’è uno che, quando si parli della sofferenza di Gesú è da richiamare, Antico Testamento: il titolo Servo di Jhaweh di cui al 2 Isaia, figura che ritroviamo al salmo 21 (o 22 a seconda della traduzione che si possiede).
Vi sono profetizzate, anche, sofferenze spirituali del Salvatore.
Per quanto riguarda il 2 Isaia, il testo più completo è nel capitolo 53, che invito a leggere interamente, e in particolare in questi
Versetti
All’inizio del 3: “Disprezzato, ripudiato dagli uomini…”
Nel 7: ”… come pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aprì bocca”.
Nel 9: “… e il suo sepolcro è con i malfattori, benché non abbia commesso violenza e non vi fosse inganno nella sua bocca”.
Inizio dell’11: “Dopo l’angoscia della sua anima vedrà la luce…”.
Dicevo che anche il Salmo 21 (22) preannuncia, tra l’altro, le sofferenze dell’anima di Gesú; nei seguenti
Versetti
1: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Tu sei lontano dalla mia salvezza”:
sono le parole del mio lamento.
2: “Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo.
ECCO: QUI E’ ESPRESSO IL DOLORE DEL SENTIRSI ABBANDONATO DEL TUTTO DA DIO, LA VERA E SOLA FORZA.
7: Ma io sono verme, non uomo, infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo.
ABBIAMO QUI PREANNUNCIATO IL SENTIRSI RIFIUTATO PROPRIO DA COLORO CHE GESÚ È VENUTO A SALVARE E IL VENIRE CONSIDERATO, IN PARTICOLARE DA CAIFA E DAI SUOI MENO DI UN UOMO, ADDIRITTURA COME UN VERME DA SCHIACCIARE.
8: Mi scherniscono quelli che mi vedono
NON SOLO RIFIUTATO, MA SCHERNITO.
Nel versetto 11:
L’angoscia è vicina e nessuno mi aiuta.
Versetto 17:
Un branco di cani mi circonda mi assedia una banda di malvagi
E’ ASSOLUTAMENTE SOLO NELL’AGGRESSIONE DEI MALVAGI, SENZA CHE NESSUN AMICO LO AIUTI.
Nel 18: Essi mi guardano, mi osservano
LA SOFFERENZA MORALE DEL VEDERSI DAVANTI GLI EMPI NEMICI CHE APPAIONO TRIONFANTI, MENTRE IL GIUSTO STA MORENDO IN MODO ATROCE.
Anche per questo Salmo, invito a leggerlo tutto sulla Bibbia di casa.
Per quanto riguarda il Nuovo Testamento, sono essenziali, per il tema che stiamo trattando, i vangeli sinottici. Il vangelo secondo Giovanni ci presenta invece un altro aspetto della Passione. Essa è già, per Giovanni, simbolicamente, glorificazione di Cristo. Tutta la sua umiliazione è presentata, in emblema, nell’episodio della lavanda dei piedi agli apostoli che è sì un gesto di umiltà ma è soprattutto simbolo dell’umiliazione di Gesú durante la Passione; poi però, si tratta di una sorta di marcia trionfale del Salvatore. Tutto è diretto da lui, sempre serenissimo.
Tratteremo, prima della sofferenza dell’anima di Gesú durante la Passione e poi di quella di tutta la sua vita.
II ) – LA SOFFERENZA DELL’ANIMA DI GESU’ DURANTE LA PASSIONE
Mentre le sofferenze corporali del Signore sono riassunte davanti a noi sulla croce, e non è così per le sofferenze della sua anima. Non sono percepibili dai nostri sensi e, pienamente, neppure dal nostro pensiero.
Sappiamo che esse iniziano prima di quelle corporali. La sofferenza dell’anima e non ancora del corpo (l’agonia, l’angoscia) è il primo atto della Passione.
Matteo (26, 38) riferisce che Gesú, una volta giunto coi suoi al Getsemani, dice a Pietro, Giacomo e Giovanni: “La mia anima è triste fino alla morte”.
In un suo discorso della fine del XIX secolo, un noto teologo parlando di quella che definiva la sofferenza mentale di Gesú, diceva addirittura che se Cristo soffrì nel corpo, in realtà fu nella sua anima dove soffrì: il corpo non faceva che trasmettere il dolore all’anima: questa riceveva il dolore ed era la sede dell’angoscia.
Se il primo punto, che la sofferenza fisica sia in realtà solo dell’anima, appare per lo meno discutibile, non c’è invece dubbio che l’angoscia ha sede nello spirito di Gesú.
È nel piano di Dio che l’angoscia di Cristo sia piena. Gesú eviterebbe ben volentieri i dolori e la morte in croce (Se possibile, passi da me questo calice – Matteo 26, 39) se fosse il volere del Padre. Però, obbediente, sceglie la diversa volontà di Dio. Per questo, quando al momento della crocifissione gli offriranno, come nell’uso, pietosamente potremmo dire, una bevanda di vino mescolato a mirra (o a fiele) che dà un qualche stordimento alla mente, dopo averla assaggiata ed essersi accorto di cosa si tratta, rifiuterà di bere; appunto perché quella bevanda in parte obnubilerebbe la sua mente, mentre egli accetta di sopportare tutta l’amarezza mentale, non solo il dolore fisico.
Tutto inizia nell’intimo, dicevo, una volta giunto nel podere Getsemani: col sentire paura e con l’angoscia che fa sentire soli (Marco, 14, 33): è soprattutto in quest’orto che i sinottici lasciano trasparire l’agonia di Gesú: di più Matteo e Marco, mentre Luca cerca di attenuarne l’angoscia presentandolo relativamente padrone di sé e della circostanza.
Ogni essere umano soffre l’ansia dell’attesa del dolore, della sofferenza futura, sia quella solo potenziale sia quella che si aspetta con sicurezza; e Gesú sa cosa l’attende. Il suo avere paura indica bene la situazione di insicurezza in cui si trova. Dopo aver loro manifestato la tristezza fino alla morte, chiede a Pietro, Giacomo e Giovanni (Matteo, 26, 39): restate qui e vegliate con me. Matteo e Marco (rispettivamente 26,41 e 14,38) sono lapidari e assolutamente efficaci nel rappresentare questa sofferenza psicologica, riportando l’affermazione di Gesú: La carne è debole. Più volte Gesú prega il Padre nel Getsemani.
Durante questa preghiera, il sudare sangue è il segno di un profondo tormento del suo cuore di uomo. Questa preghiera è un incontro tra l’umana volontà di Gesú e l’eterna volontà di Dio. Il Figlio s’era incarnato perché questo incontro fosse colmo della verità sulla volontà e sul cuore umano, che vogliono fuggire il male (il peccato), la sofferenza e la morte. S’era fatto uomo perché, su quella verità, si rivelasse tutta la grandezza dell’Amore, che si esprime attraverso il dono di sé stesso nel sacrificio:
Dio ha tanto amato il mondo che ha sacrificato il suo Figlio unigenito (Giovanni, 3, 16) e in questa ora, quell’eterno Amore deve verificarsi col sacrificio del cuore umano. Cristo non rinuncia a dare il proprio cuore affinché divenga altare, un luogo di totale annientamento, prima ancora che lo divenga la Croce. La volontà umana, che esprime la verità umana Se possibile, passi da me…, è anche la volontà dell’uomo che si dà alla volontà di Dio, come passando oltre la verità umana, oltre a quanto fa sentire il cuore; e prende su sé sia l’eterno giudizio del Padre e del Figlio nell’unità dello Spirito Santo sia la potenza, che scaturisce dalla volontà di Dio: Dio che è Amore.
All’inizio, nel Getsemani, Dio non s’è ancora nascosto, ma si sta allontanando; e a un certo punto Gesú non riesce più a comunicare direttamente: ne abbiamo simbolo in Luca, dove troviamo l’angelo mandato dal Padre che lo fortifica per la sofferenza: un messaggero, non Dio stesso.
Gesú si trova solo pure di fronte ai discepoli; cioè, quella che sarà la sua stessa Chiesa è presente ma è spiritualmente assente.
Tutto ciò che riesce a distogliere dal pensiero della sofferenza, lo mitiga. Gli amici possono alleviare il dolore patendo con, compatendo. Ora Cristo vorrebbe il conforto, in quell’ora, degli altri; ma Pietro e i figli di Zebedeo, invece di pregare con lui, si addormentano, e la sofferenza spirituale di Gesú rimane totale.
Non è solo questione di quell’ora nella sua storicità; essa appartiene sì al passato, ma rimane per sempre nell’Eternità divina.
Questo è per noi!
Il Signore ci consente di incontrarci con lui in quell’ora. Diventa colmo di significato quel Vegliate! per non cadere in tentazione! pronunciato da Gesú. Egli trasferisce su di noi quell’ora della prova suprema che è anche prova in ogni tempo per noi discepoli, per la Chiesa.
Io sono la vera vite …(Giovanni, 15, 1). Come il tralcio non può da sé portare frutto se non rimane unito alla vite, così nemmeno voi, se non rimanete in me…(Giovanni, 15, 4).
Tornando a quell’ora storica, ecco che, trovando i discepoli addormentati, Gesú si rivolge di nuovo al Padre per essere liberato.
Sappiamo che ha profonda paura di quanto l’aspetta, conoscendo la sua Passione prima di essere arrestato, per il suo essere anche Dio; e il fatto che Dio gli si nasconda non significa che, dopo, Gesú non ritenga nella memoria quanto in proposito il Padre gli aveva prima rivelato sulla sua sofferenza; anzi, è parte della sua sofferenza spirituale che l’anima di Cristo non si trovi improvvisamente nella tempesta della Passione, come per caso, ma già la soffra quale attesa; Gesú l’aveva predetta più volte agli apostoli.
Se niente ha effetto su Cristo senza ch’egli, come Dio, lo voglia, come uomo, come ogni uomo, Gesú ha piena libertà; e ha spontanei sentimenti in tutte le sue espressioni. Tuttavia, l’iniziativa di Dio di nascondersi a Cristo, veniva da Dio, quasi come se l’uomo Gesú non avesse potuto dire di no. È vero che precisava che può soffrire mentalmente la Passione perché a quella sofferenza deliberatamente si sottopone; ma aggiungeva che nel Getsemani Cristo, come Dio, dà l’ordine a sé di sottrarre la sua anima umana al sostegno della divinità, e viene invaso da angoscia, poi da terrore. Da quel momento, aggiungeva, il Dio che è lui si nasconde all’uomo che è lui. In altre parole, l’accento sul potere di Gesú–Dio: la sua natura divina, per lui, dirigeva fermamente tutti i movimenti della sua natura umana.
È una posizione che può apparire estrema; l’antica scuola teologica di Alessandria (Clemente, Atanasio, Origene) che vedeva con particolare favore la natura divina di Gesú.
Oggi si tiene conto anche dei risultati della parimenti antica scuola di Antiochia, che focalizzava piuttosto su Gesú vero uomo per poi salire a Gesú vero Dio. Perciò si mette in risalto la assoluta libertà di Gesú-uomo, il suo poter scegliere di dire no e il valore del suo scegliere, viceversa, di dire sì a Dio.
A mezzo dell’autore della Lettera agli Ebrei, (10, 5 – 7, versetti che fanno riferimento al Salmo 40, 7 – 9), sappiamo che Gesú dice, rivolgendosi a Dio: cioè conosciamo questo atteggiamento di Gesú:
Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo, invece, mi hai preparato.
Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.
Allora ho detto: Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro –
per fare, o Dio, la tua volontà.
“Ed è appunto per quella volontà”, aggiunge l‘autore della lettera (al versetto 10), “che noi siamo stati santificati, per mezzo dell’offerta del corpo di Gesú Cristo, fatta una volta per sempre”: quella volontà di Dio e quella volontà, quella scelta di Gesú-uomo di obbedire.
C’è chi si può chiedere se Gesú non avesse alcune consolazioni relative a lui solo, essendo anche Dio, che alleviassero l’angoscia della sua anima umana, che gli facessero sentire il dolore meno vivamente rispetto a un altro uomo.
Una volta un mio amico, non credente ma in ricerca, mi aveva detto: “Bella forza! Era anche Dio! Bisogna vedere come se la sarebbe cavata se fosse stato solo uomo”.
No, semmai le sue sofferenze spirituali sono più intense.
Noi sappiamo di essere peccatori, se riceviamo un’ingiusta calunnia o addirittura un’ingiusta punizione, certo abbiamo ragione di lamentarci, ma sappiamo di non essere stati, nel complesso della nostra vita, sempre innocenti in tutto. Gesú invece ha il sentimento pieno della sua assoluta innocenza. Sa di essere il perfetto uomo giusto che viene umiliato ingiustamente da altri uomini, loro sì peccatori. La sofferenza per l’ingiustizia subita è totale. Non è giusto pensare che Gesú venga sostenuto nella sua prova dalla consapevolezza della sua innocenza ma, anzi, è al contrario.
Ci sono poi coloro che dicono che Cristo, come Dio, sapeva che le sue sofferenze avrebbero avuto, relativamente, breve durata, che sarebbero finite verso le tre di quel venerdì; e richiamano in proposito il dolore di chi è stato umiliato per mesi o anni e ammazzato a poco a poco nei lager e nei gulag senza sapere se e quando sarebbe finita; e dicono che Gesú sapeva che le sue sofferenze si sarebbero risolte nella gioia assoluta, mentre l’incertezza del futuro è una delle cose che angosciano la mente.
Ma è facile ribattere che, visto che Dio gli si è nascosto, non è corretto affermare che Gesú durante la Passione ha conoscenza della sua Glorificazione. Ha conoscenza della sua missione, questo sì, una consapevolezza che non l’abbandona neppure per un istante: sa di dover arrivare fino alla morte per la nostra salvezza; e ci arriva! A differenza della prescienza delle sofferenze che via via incontrerà, la consolazione del sapere della sua Gloria viene invece a mancargli: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”
C’è infine chi ricorda che l’autore della Lettera agli Ebrei afferma (12, 2) : …Egli in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando l’ignominia, e si è assiso alla destra del trono di Dio.
Già, ma… la gioia di chi aveva davanti?
La nostra!
Gesú è Dio che scende in terra, non ha bisogno di conquistarsi il Regno dei Cieli, perché è già lui il Regno dei Cieli, sia fuori dal tempo sia nel mondo creato da lui, Dio unico e trino.
Anche quell’affermazione, dunque, è fuori luogo.
Il fatto che il Figlio non ha bisogno d’innalzarsi, non toglie che nell’incarnarsi Dio si abbassa.
“Dio soffre nella sua natura umana e le sofferenze sono volutamente bevute sino in fondo”.
Ma soffre davvero solo nella sua natura umana?
Sulla croce sale anche Dio; e tutto Dio soffre sulla croce. Come Figlio-Dio che si offre, come Padre-Dio che lo offre, come Spirito-Dio che è l’Amore che promana dal loro amore sofferente. Una sofferenza attiva però, non passiva come quella della mentalità greca che aveva a presupposto l’impassibilità di Dio. Il Dio cristiano soffre un dolore attivo scelto liberamente, un dolore che è perfetto perché ha la perfezione dell’Amore. Da quel venerdì ci è noto che tutta la storia delle nostre umane sofferenze è pure storia del Dio con noi.
E prima della Croce, Dio Padre, Figlio e Spirito soffre in quel suo nascondersi a Gesú uomo mentre Gesú uomo soffre per quel nascondimento di Dio.
Come Dio possa soffrire è un mistero; ma sappiamo che soffre perché c’è unione nella stessa Persona del Figlio della natura divina e di quella umana e perché Dio è sì in tre Persone ma Uno: per quell’unione, soffrendo Gesú uomo, soffre anche Dio; non sembra giustificato dire che il Figlio soffre solo come uomo.
Per Cristo è davvero, totalmente, un’agonia mentale terribile.
L’angoscia piena che soffre comporta che l’amarezza riempia interamente la sua mente. In quel momento l’anima umana di Gesú non sente lo splendido avvenire, soffre soltanto il peso che è su di lui; eppure, rimane determinato ad andare sino in fondo!
Il peso su di lui è quello dei peccati di tutto il mondo in ogni tempo.
Gesú è sì vittima dei peccati dei suoi nemici, come quello di Giuda che lo tradisce e lo consegna; ma sente il peso dei peccati soprattutto nell’essere reso lui stesso peccato.
Nel primo senso, il nostro peccato, è una rivolta contro Dio; è odiare Dio, è odiare Gesú (e con lui il prossimo). Cristo sente addosso alla sua anima tutto l’odio dell’umanità peccatrice.
Non appena l’Amore infinito entra nell’immanente da lui creato, come uomo si sottomette alle sue leggi; il peccato, nemico della verità, del bene, cerca vantaggio da una situazione che è per lui favorevole; e così, tra l’altro, ecco l’odio dei farisei e dei sacerdoti, ecco il grido di quella parte della folla che vuole che Gesú sia crocifisso: sono peccati che pesano gravissimi sulla mente di Cristo.
Il peccato non può toccare Dio ma lo assale nella sua umanità creando spavento nell’anima di Gesú-uomo.
Ma non si tratta, come dicevo, solo del peccato che Gesú subisce come vittima in certe situazioni della sua vita.
In Paolo troviamo:
Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi, come sta scritto: Maledetto chi pende dal legno (Gàlati, 3, 13)
Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio (II Corinzi, 5, 21).
Alla lettera, lo fece diventare peccato
Come Messia, Cristo è senza peccato, tuttavia Dio lo manda in una carne simile a quella del peccato (Romani, 8, 3) e così diviene, lui innocente, parte dell’umanità peccatrice in solidarietà con la condizione umana, soffrendo le conseguenze del peccato (Gàlati 3, 13).
Dunque, durante la Passione resta prostrato; il suo nemico, il peccato dell’uomo, avvolge la sua anima, riempie la sua coscienza e la sgomenta. Lui innocente, prendendo su di sé il peccato, milioni e milioni di nefandezze, si sente come un peccatore sommo, ha percezione vivissima del male pieno che è entrato nella sua mente. si sente in quei momenti come se fosse proprietà del maligno, non di Dio.
Il teologo Hans Urs von Balthasar, nel suo saggio “Teologia dei tre giorni”, presenta in particolare la questione teologica se l’angoscia di Gesú nell’orto degli ulivi comprenda anche il timore della Gehenna, se Gesú cioè provi il sentimento di essere dannato.
Espressa così, la domanda fa tremare i polsi. Vediamo di arrivare a un’altra espressione, forse un po’ meno tremenda.
La Gehenna era un luogo presso Gerusalemme in cui, ai tempi di Gesú, si bruciavano le immondizie. Per il sentire di quel tempo, che non conosceva il nulla si crea e nulla si distrugge, ciò che bruciava moriva, non era più. Lo stesso luogo era considerato maledetto perché secoli prima vi erano svolti sacrifici umani, soprattutto di bambini, al dio Moloch: Moloch è anche, presso gli Ebrei, uno dei soprannomi del diavolo; maledetto è tutto ciò da cui Dio distoglie lo sguardo, in altre parole che non è nell’Essere di Dio ma nel nulla.
Possiamo allora esprimere il problema così: Fa parte della sofferenza dell’anima di Gesú anche il temere di non risorgere dal sepolcro, cioè di restare morto, ovvero nella Gehenna?
Se rispondiamo affermativamente, possiamo farlo solo avendo ben presente che l’angoscia nell’orto degli ulivi è un com-patire con i peccatori. Von Balthasar: “La perdita reale di Dio che li minaccia è assunta dall’amore di Dio fattosi uomo nella forma di timor gehennalis: poiché i peccati del mondo vengono ‘caricati’ su di lui, Gesú non distingue più sé stesso o il proprio destino da quello dei peccatori (…) e sperimenta perciò l’angoscia e il terrore che essi avrebbero dovuto giustamente provare”.
In altre parole, i peccati a Gesú non appartengono ma egli soffre per noi come se ne fosse l’autore.
Questa, di subire la conseguenza dei peccati, lui innocente, di sentirli in sé come se fossero suoi è la più atroce delle sofferenze spirituali di Gesú durante la Passione.
Finalmente, sulla croce, appena prima di morire, egli pronuncia, richiamando il Salmo 31, 6: “Padre, nelle tue mani affido la mia anima” (Luca, 23, 46), cioè ti affido la mia vita, la mia Vita eterna.
A questo punto Dio non gli è nascosto. Nell’affidarsi al Padre, Gesú usa la parola Abbà, cioè babbo, papà; addirittura potremmo dire babbino, paparino. Prima invece (Matteo e Marco), pronunciando il “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” aveva usato il termine Elì, nome divino che si pronuncia con tremore. Alla lettera infatti aveva pronunciato il primo versetto del Salmo 21 che, come avevo accennato, nella prima parte ci parla della disperazione del Servo di Jahvé di cui al 2 Isaia. Un Salmo che però finisce nella piena vittoria, nella Gloria.
L’obbedienza di Gesú al Padre, quell’obbedienza che lo porta a soffrire spiritualmente e fisicamente, è presente anche nella morte stessa di Cristo, “ultima conseguenza della missione redentiva ricevuta dal Padre”.
Quel suo raccomandarsi al Padre nel momento di morire e quell’offrire la sua morte a Dio sono anche per noi.
III ) ANCHE PER GESU’ LE SOFFERENZE NON INIZIANO CON LA PASSIONE IN SENSO STRETTO MA SONO PRESENTI IN TUTTA LA SUA VITA
In una certa misura gli avvenimenti precedenti la Passione costituiscono un’anticipazione della croce. Sappiamo che gli Evangeli non ci parlano di tutta la vita di Gesú. Ci avevano provato gli apocrifi, ma non sono Parola di Dio. Sebbene sia possibile che contengano qualche notizia vera, tramandata oralmente fino al II secolo e oltre, non essendocene prova, non si possono considerare.
Gli evangelisti canonici hanno voluto mettere in risalto prima di tutto la grandezza di Gesú Cristo, i suoi poteri, il suo eroismo assoluto, il suo essere anche Dio; e naturalmente la sua Risurrezione. A parte che per la Passione, non molto si parla nei Vangeli della sofferenza di Gesú
Qualcosa però si può dire a proposito delle sue ansie, delle sue umane crisi, delle sue lacrime, delle sue limitatezze tipiche di ogni vero uomo, e delle sue lotte psicologiche per realizzarsi e realizzare il suo ideale divino.
L’autore della Lettera agli Ebrei (5, 8) ci dice di lui: Anche se figlio, ha imparato attraverso quello che ha sofferto l’ubbidienza.
Il Vangelo secondo Luca afferma di Gesú sinteticamente, per tutti gli anni della sua infanzia: Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui (2, 40). Sappiamo così della già perfetta personalità di Gesú.
Poco oltre, al versetto 52, quando Cristo ha ormai dodici anni, dopo l’episodio della discussione nel Tempio coi dottori della Legge, Luca aggiunge, per quel tempo di mezzo di cui non abbiamo altre notizie canoniche: E Gesú cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Allora, possiamo pensare a una crescita di Gesú-uomo, per esperienza, a un sofferto cammino spirituale, fino alla pienezza che manifesterà durante la sua vita pubblica.
Possiamo ritenere, tenendo presenti entrambi i versetti di Luca, che la già perfetta personalità di Gesú viene da lui scoperta a poco a poco.
È per questa sua esperienza che Dio non è giudice delle sue creature dal di fuori ma dall’interno.
La teologia ha attribuito a Cristo molteplici forme di scienza: essendo Dio, quella infinita, come uomo perfetto senza peccato quella che era stata di Adamo prima del peccato e infine quella, sofferta, che gli viene dall’esperienza, come per tutti noi; ma pare che gli Evangeli gli riconoscano solo quella sperimentale, che è progressiva.
Sappiamo che si accumulano davanti a lui segni della sua missione divina, sino a che, durante l’ultimo suo tempo sulla terra, quel poco tempo che gli resta prima della morte, Gesú predice la sua Passione, più volte, agli apostoli: (Marco 8, 31 seguenti; 9, 30 seguenti; 10, 32 seguenti).
Non sappiamo in che modo Cristo si senta anche Dio. Lo sa, di esserlo, almeno da un certo punto della sua vita pubblica, da quando lo dice chiaramente, e più volte; ad esempio: “Chi vede me vede il Padre”; ma come ciò sia, non sappiamo. Non conosciamo dunque il suo grado di incertezza prima di quelle proclamazioni. Inoltre, anche dopo, la sua consapevolezza non arriva al punto ch’egli possa capire ed affermare, come uomo: Io sono il Figlio di Dio quale seconda Persona della Trinità, perché per un’umana coscienza non è possibile. È esistenzialmente che Gesú lo esperimenta e lo vive, quel suo essere Dio, nel suo atteggiamento di obbedienza al Padre. Si può pensare che arrivi alla consapevolezza della sua divinità in modo sofferto, sia in seguito alla sua riflessione sia grazie agli interventi del Padre che, per prima cosa nella preghiera di Gesú a Lui, lo illuminano nei momento giusti.
Solo dopo essere risorto, apparso sul monte in Galilea, Cristo dice agli apostoli: “… Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra” (Matteo, 28, 18). Prima, Gesú lotta per conoscersi sempre più, per chiarire la propria vocazione e stabilire come metterla in atto, per capire il Piano salvifico. Come noi, prova i quotidiani dolori, la fatica, l’insuccesso, il pianto. Solo il contatto col Padre riesce a rendergli chiari e a fargli superare gli ostacoli, come il desiderio d’una serenità familiare, la solitudine in cui, di fondo, si trova, le fatiche del suo lavoro missionario, l’ostilità dei nemici, la lotta con le passioni, con l’istinto.
Conosciamo dagli evangelisti che la sofferenza spirituale di Gesú comprende il dolore per la morte degli amici.
Matteo (14, 13), ci fa capire la profondità della sofferenza di Gesú per l’uccisione di Giovanni il Battista: Udito ciò, Gesú partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto.
Giovanni ci parla delle sue lacrime per la morte di Lazzaro (11, 33-35): Gesú allora quando la vide piangere e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: “Dove l’avete posto?”. Gli dissero: “Signore, vieni a vedere”. Gesú scoppiò in pianto.
A proposito di turbamento, Giovanni usa questa stessa parola (12, 27 – 28) quando riporta queste di Cristo, mentre giunge l’ora della Passione: Ora l’anima mia è turbata; e che devo dire? Padre salvami da quest’ora? Ma per questo sono giunto a quest’ora! Padre glorifica il tuo nome… Il fatto che sia usata qui la medesima parola, turbamento, testimonia la profondità del dolore di Gesú per la morte dei suoi amici.
C’è inoltre un’amarezza in lui per l’incomprensione dei suoi concittadini. Così, Luca ci dice del loro attacco scandalizzato, dopo che Cristo ha parlato loro nella sinagoga (4, 28 – 30): All’udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno; si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò.
Qui Luca, con intento apologetico direi, ci presenta un Gesú che senza sforzo si svincola e se ne va tranquillamente; ma tenendo conto del contesto non possiamo non pensare a una fuga precipitosa: Nazaret non sorge su un monte, nella realtà. Vicino alla città c’è solo un piccolo precipizio. Quel monte immaginario può essere sì un preannuncio del Calvario, ma pure un modo di Luca per dirci, tra le righe, della drammaticità della situazione, per suggerirci la tensione che è in Gesú in quei momenti e che si accompagna all’amarezza per quell’insuccesso, avvenuto proprio nella sua patria e all’accoramento per lo spavento avuto da sua madre..
Avevo ricordato prima l’espressione di Gesú in Matteo e Marco: la carne è debole.
L’autore della Lettera agli Ebrei (5, 7) definisce i giorni della vita terrena di Gesú “come i giorni della sua carne”.
La carne ci dice della fragilità, dell’imperfezione della sua natura umana non ancora in Gloria; carne che segna l’umanità di Cristo.
E tra quanto Gesú soffre spiritualmente a causa della sua carne, ci sono, gravi, le tentazioni
che lo conducono a com-patire noi tentati.
Nella Lettera agli Ebrei la tentazione è vista in collegamento con l’insieme del soffrire di Gesú:
Infatti, proprio per essere stato messo alla prova ed avere sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova (2, 18).
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa a somiglianza di noi, escluso il peccato (4, 15): tentato anche lui, anche se mai peccatore, Gesú comprende le nostre infermità, cioè i nostri difetti, i nostri peccati.
Troviamo le tentazioni che aggrediscono Cristo riassunte nel deserto (Matteo, 4, 1 – 11 e Luca, 4, 1 – 13) ma esse riguardano tutta la vita sulla terra di Gesú, non solo quei quaranta giorni. Ad esempio, è tentato da Pietro, in questo caso strumento di satana, di non andare a Gerusalemme (Matteo, 16, 22); e c’è una reale lotta col diavolo anche attraverso i nemici che sfidano il suo orgoglio, “maestro, vorremmo che tu ci facessi vedere un segno” (Matteo, 12, 38) e poi addirittura che lo sfidano ai piedi della croce, dicendo che se è chi dice di essere, allora scenda dalla croce, e loro crederanno (Matteo 27, 41).
Le tentazioni sottolineano la sofferta possibilità di Cristo di fare scelte, e in particolare una scelta diversa da quella che Dio gli propone al momento del battesimo (Matteo, 3, 17.): Ed ecco una voce dal cielo che disse: ‘ Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto’ (v. anche Marco 1, 11).
Le scelte hanno sempre in sé una componente, per dirla modernamente, di stress. Così, cose come il non scegliere un cammino di vita il più possibile tranquillo, il rinunciare a vivere una gloria meramente umana sono il risultato di una opzione sofferta; per non parlare di quella ultima, nei Getsemani.
La scelta essenziale che ognuno fa è quella in coscienza di testimoniare la verità che conosce, nell’altruismo, oppure di andarle contro, nell’egoismo; cioè di essere giusto oppure peccatore.
Possiamo insomma parlare di un doloroso cammino spirituale dell’uomo Gesú e di un suo pesante sforzo psicologico per arrivare a scoprire la sua personalità già perfetta.
È meritatamente ch’egli giunge alla Gloria: si tratta della mèta di tutta la sua vita, da conquistare. Lotta e prega per questo. Prega per il genere umano, ma prega in modo particolare per sé, per riuscire a superare le cattive inclinazioni della carne. È Dio ed è uomo, ma la sua lotta è come uomo, vero, del tutto eguale a noi se non per l’assenza in lui del peccato: perché sempre lo rifiuta. Nel corso della sua vita terrena, la sua ragione, la sua volontà… tutto quanto è della sua anima deve essere mondato dall’imperfezione della carne. Nel Battesimo lo Spirito Santo gli dà Forza per la missione che deve svolgere. Quello stesso Spirito per cui c’è stata la sua Incarnazione, che consente che sia tentato per esserne corroborato, quello stesso Spirito divino abbraccia e sostiene la sua anima umana; nel consacrarlo lo rende adatto, forte nell’opera di Salvezza che ha da svolgere; senza togliergli la libertà.
IV – PER CRISTO, E DUNQUE PER IL CRISTIANESIMO, IL DOLORE IN SÉ È UN BENE?
Nella storia il dolore è stato innalzato da correnti spirituali a bene cristiano; ma Gesú, come uomo, pregando il Padre di allontanargli, se possibile, il calice del dolore e della morte, dimostra di non essere naturalmente orientato a loro. Cristo accetta nel momento supremo di fare la volontà di Dio e dunque di essere arrestato, torturato e crocifisso per testimoniare la Verità (la sua Rivelazione) sino in fondo: in quel momento storico-politico, in quel contesto sociale e religioso, le sue scelte hanno come conseguenza inevitabile la tortura e la morte; e Gesú-uomo lo sa e l’accetta; ma in quanto quei dolori e la morte sono in quel momento necessari alla testimonianza della Verità
Gesú non è venuto a insegnarci a soffrire per soffrire, ma a testimoniare la verità, la giustizia, la carità e così indirizzarci alla gioia, nell’ubbidienza a Dio.
Cristo, è vero, ci dice che chi lo ama deve prendere la sua croce e seguirlo, ma non dice che si deve andare a cercarla apposta, come un valore in sé.
La sofferenza è una conseguenza della scelta di carità e, quando ci arriva addosso inaspettata, quale prova che ci viene data, essa è uno strumento che ci mette appunto alla prova, perché dimostriamo il nostro amore a Dio nonostante la sofferenza; e trovando conforto, quando ci tocchi di portare una croce, col sopportarla in unione e per amore a Cristo.
Quanto dobbiamo fare è evitare ciò che Gesú condanna: il male. Il Regno dei Cieli che Cristo ci indica comporta che noi, sulla terra, cerchiamo per quanto possibile di realizzare con e verso il prossimo l’Eden qui, nel mondo: cioè la gioia. Dio ci ha dunque creati per essere felici, non per avere sofferenza. Avere gioia per la sofferenza che ci aggredisce sarebbe davvero innaturale, una violenza alla nostra ragione e al nostro istinto.
Gesú dice: “Vegliate!”.
Lo Spirito Santo ci aiuti ponendo nel cuore un desiderio più grande di preghiera, di studio della Parola. Sì, chiediamo il sostegno dello Spirito Santo perché aiuti a esercitare il più possibile quell’amore verso il mondo, quell’amore per la gioia che Gesú è venuto a insegnarci.












 Follow
Follow

 comments feed
comments feed

















Lascia un commento